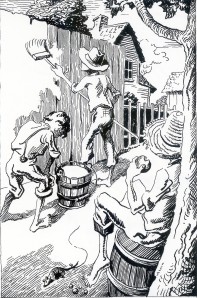Il Dio Cristiano, che non è quel Dio lì ma uno che per passione delle serie tivvù era solito farsi chiamare DC puntato con pronuncia anglosassone, creò il giardino a immagine e somiglianza dell’Eden. Là dentro ci infilò gli orfani della sciura Maria, della sciura Lucia e della sciura Rosina, trovatelli del deserto. Ebbe subito cura di loro e perdonò tutti quelli che avevano peccato. Dopodiché si prese la briga di occupare le loro giornate: gli affidò l’incarico di dipingere il recinto con colore omogeneo. Dopo l’iniziale entusiasmo, gli ospiti ben presto ebbero a scontrarsi aspramente: i figli della sciura Rosina sostenevano che il nero fosse demodè, ricordava la morte e portava tristezza, e che le leggi della moda ormai imponevano colori accesi e passionari, e questa era per certo la posizione maggioritaria. Mentre quelli litigavano sulla dicotomia del colore, Dio di tanto in tanto convocava i più bravi e carismatici a cui affidava incarichi d’amministrazione: niente più steccati e pennelli, ma pratiche organizzative in ufficio. Intanto quelli che restavano in giardino continuavano a litigare, e litigavano talmente bene sul colore da scordarsi l’esistenza dello steccato: nessuno si accorse che il Principale aveva già contattato una di quelle ditte leader del settore, che s’impegnò a pittarlo in soli tre giorni: avrebbe dovuto essere un colore nuovo con reticenze antiche, tra l’Azzurro Savoia e il Blu di Prussia.
La Rivoluzione e il tè delle cinque
Come quel dì nella Repubblica d’Alloro in cui la situazione giunse a un sottile e fanciullesco idillio della morte. Resurrezione e rinascita sembravano così distanti e così contigue al caso del presente, inasprito dalla miseria e infuocato dai tumulti.
Popolani, contadini, braccianti, ricchi proprietari, distinti faccendieri, altolocati signori mostravano insofferenza e si rifacevano al più antico gioco della frittata, una danza propiziatoria in cui si chiede conto dell’operato del Re.Che poi ci fosse il Re in una Repubblica era sicuramente fatto curioso, difatti la contraddizione mostrava segni d’apparente cedimento. Il Re dal canto suo si prodigava a rassicurare i cittadini ormai da lungo tempo, e tra i vari ministri che a turno si erano avvicendati al Triumvirato mai ve n’era stato uno capace di risolvere i vari squilibri che la Repubblica pareva soffrire.
Le lotte ben presto divennero sempre più aspre, e il malcontento venne alimentato anche dal repentino cambio di vescovo: il nuovo episcopo sembrò da subito cordiale e dinamico, senza rinunciare a strizzare l’occhio verso il cuore della rivolta. Intanto anche la Contessa Clementina Aloe Mosconi assieme al marito, il Conte Giovanni Romili Gazzoletti aveva iniziato con fervore a sostenere il cambio di rotta, non disdegnando di organizzare con gli abitudinari ospiti del suo salotto strategie metodiche di guerriglia urbana. Gli scontri con l’esercito erano competenza dei contadini e dei padri di famiglie numerose, secondo una consumata tradizione tramandata dalla valle del Pathos all’altopiano delle Lacrime. L’esercito picchiava duro, anche perché i gruppi di protesta erano vari e ben articolati, tutti con una peculiarità principale: chi sapeva cantare, chi era un portento nella danza, chi ragionava senza ansie di sorta e chi s’infiammava d’istinto e chi bruciava d’impulso.
Non tutti i gruppi erano ben coordinati e, diciamo la verità, alcuni erano in asprissima opposizione. Chi cantava non sopportava tanto coloro che si dilettavano nella danza, e questo comportò un’irrimediabile opposizione asimmetrica: alcuni dei razionali finirono coi cantanti, altri con i ballerini, e allo stesso modo fecero gli incendiari. La dicotomia strideva quotidianamente e veniva regolata con sistematiche prove organizzate dal Triumvirato in cui i contendenti erano obbligati a ripetere dodici prove di abilità, che di solito non prevedevano alcun reale vincitore. Certo, i cantanti venivano solitamente trattati meglio soltanto perché il nonno del Re era tenore e venne ucciso da un danzatore invidioso, tuttavia entrambe le parti godevano per buona salute e spirito di competizione. Da una parte i cantanti sostenevano con ardore la propria presunta superiorità, nel rispetto del Re e in quella volontà di staticità che portava a guardare i danzatori come una pericolosa deriva dittatoriale, fondata sul movimento: non il Movimento in senso lato, ma il movimento in senso ginnico. La ginnastica difatti veniva guardata con sospetto, e fu bandita in circoli di canto.
Tuttavia il malcontento nei confronti del reame montava da mesi, e quel giorno tutti scesero nella grande piazza a intonare cori minacciosi, e li intonavano tutti: i cantanti, e i danzatori. E mentre i tenori accusavano i danzatori di attivare pratiche di protesta poco consone al proprio ruolo, i danzatori erano decisi a cambiare musica sull’onda dello slogan “Bruciate gli spartiti”. Le varie poesie cantate da entrambi i gruppi venivano regolate da menestrelli finanziati dalla Contessa, che aveva a cuore un po’ tutte le fazioni ma pretendeva si facesse comunque Rivoluzione. Dopo un lungo conciliabolo tra i letterati del suo salotto, si stabilì la data: la Rivoluzione si doveva iniziare dal 9 dicembre a partire dalle 17 e contando 57 secondi tra l’undicesimo e il dodicesimo minuto sull’orologio a pendolo della Cattedrale, dopo l’ora del tè, eccezionalmente e opportunamente anticipata.
Dialogo sul Primo Maggio
– Anch’io voglio essere felice. Cosa posso fare?
– Per essere felici bisogna prima realizzarsi. Potresti imparare un mestiere e trovarti un senso.
– Un senso?
– Sì, un senso compiuto. Così si diventa uomini. E quindi, realizzati.
– E cosa potrei fare?
– Non so, vediamo: potresti farmi i lavori a casa. Curare il giardino, l’orto, prepararmi da mangiare, tenere tutto pulito e in ordine, rifarmi il letto, ripararmi le scarpe, rammendare i vestiti. In fondo viviamo sotto lo stesso tetto (sorriso).
– Ok, se lo dici tu lo farò. Ma non vedo il nesso con l’essere uomo.
– Il concetto è sentirsi utile per la causa. Tu manderai avanti la manutenzione del luogo in cui vivi. E vivere in un mondo in cui si è utili, ci nobilita.
– Sì ma… se devo fare tutte queste cose, quando ci penso al mondo, e alla mia condizione? Se non ci penso, non posso sentirmi utile. E non posso sentirmi uomo, perché non posso sentirmi nulla.
– Certo che puoi. Basta fermarsi a riflettere. E vivere a pieno la tua casa.
– Capisco. Ma se devo seguire tutte queste cose, come faccio a vivermi la casa? Quando ci penso, a me stesso?
– Hai ragione anche tu. Ti darò un giorno in cui fermarti per riflettere sulla tua utilità, e sulla tua dignità. Così penserai a quello che hai rammendato, alle piante che hai potato, alle scarpe che hai riparato, ai muri che hai imbiancato, agli ortaggi e ai frutti che hai raccolto, alle vivande che hai preparato. La realizzazione sta tutta lì.
– Ma… posso pensare anche ad altro? Voglio dire, c’è una ragazza che mi piace…
– Puoi pensare anche ad altro, ma devi dare priorità di importanza alle cose. Meglio la dignità di uomo, o una ragazza?
– Ehm…
– Capisco la tua indecisione: questo è perché sei ancora privo di una giusta scala di valori e di principi. Facciamo così: si inizia domani. Dopodomani sarà il tuo giorno di festa, poi dopodomani doppia razione, e si recupera.
I Savi
Questi erano ritenuti i saggi: Pitruzzella il Palermitano, Giovannini lo Statistico, Salvatore Rossi delle Banche, Milanesi il Romano dei Bocconi, Giorgetti di Cazzago Brabbia (detto “Il Padano”), Bubbico l’Architetto. A questi aggiungono Onida il Giurisbarone, Violante il Riformista d’Etiopia, Quagliariello il Biologico, Mauro il Civico. E alcuni dicono anche Monti il tecnocrate.
Queste le prime disposizioni:
1) “Fatti perdonare la potenza con la dolcezza; merita d’essere amato; paventa d’essere temuto”
2) “Non gesticolare mentre parli, altrimenti sembri un matto”
3) “In ogni cosa bisogna procedere lentamente”
4) “Dei morti non dire che bene” – De mortuis nil nisi bonum.
5) “Di Monti non dire che bene” – De technĭco nil nisi bonum.
6) “Bada a te stesso”
7) “Bella è la tranquillità”
8) “I piaceri sono mortali, le virtù invece immortali”
9) “Non rivelare i segreti”
10) “Attieniti a leggi vecchie e a cibi freschi”
11) “La democrazia è meglio della tirannia, soprattutto se si è in pochi amici”
“Ustica” sembra un attacco di stupore
«Ustica, Stato condannato a risarcire vittime». Oggi al banco del pesce è arrivata questa freschezza. Le parole si rincorrono coi numeri: «la sentenza 1871», e poi «27/06/1980», e «81 vittime, 77 passeggeri, 11 bambini», «IH870», «240.000 euro», «18.30», «20.08», «20.56», «21.13», «21,21», «7.05», «7.500 metri».
Roba da giocarsi una cinquina sulle ruote di Roma e Palermo. E così, tra un caffè e l’altro capisci che lo Stato ha condannato lo Stato. In pratica, tutti ci dicono che lo Stato siamo noi, ci dicono che lo Stato talvolta uccide, e poi ci dicono che lo Stato condanna lo Stato perché non ha difeso chi lo Stato rappresenta e dallo Stato è rappresentato. Quindi, ci siamo condannati perché ci siamo ammazzati. Un missile è partito e ha raggiunto quell’aereo, e lo Stato non l’ha impedito. Ed è colpevole. La sentenza 1871, mentre si occupa della breccia che distrusse l’Itavia, ricorda la Breccia che fece l’Italia, e ci dice che la responsabilità è dello Stato. In poche parole, se tuo figlio attraversa la strada sulle strisce e qualcuno lo falcia, la colpa è tua. E chi lo falcia? Chi tira i missili? I missili fanno parte del gioco, come gli automobilisti imprudenti e i proiettili vaganti in giardino durante il barbecue, che ti ammazzano il cognato e ti consegnano la responsabilità dell’accaduto. Mica possiamo stare lì a mettere i puntini sulle i. Quel missile aveva altri obiettivi, stava allo Stato sapere quali. Cioè, a noi. No, a loro. O forse a Gheddafi. Dicono che quel missile fosse per lui. Aspetta che glielo chied… ops.
I teatranti
Il bar era il centro della mondanità, quella dell’essere più che quella dell’apparire. Almeno così credeva chi il bar lo frequentava. Era pensiero diffuso cercare la verità tra un bicchiere di Greco di Tufo, sul fondo di una tazzina da caffè, tra le pagine del quotidiano maltrattato sul tavolo: ogni avventore credeva di essere se stesso, e invece era soltanto se stesso nei panni di un avventore.
Vito Alius questo lo sapeva. Lo sapeva perché conosceva bene quel bar, a due passi da casa. I tavoli di legno e le sedie in vimini attiravano spesso la sua necessità di solitudine. Sia ben chiaro, nella solitudine l’Alius ci sguazzava, quasi come fosse la sua anziana consorte. Al bar però, la solitudine era qualcosa di diverso. Era messa alla prova.
Nel frattempo, al bancone si riciclavano facce e voci, pantaloni di pelle nera e cappelli da cowboy, acconciature cotonate, piercings, barbe incolte, barbe curate, barbe eccentriche, barbe da impegnato. Dall’altra parte, baristi con sorrisi a comando e battute sagaci danzavano tra macchine del caffè, bottiglie da monopolio, spillatrici e prosciutto da affettare.
Alius amava ordinare una vodka e starsene seduto anche più di due ore. Talvolta, nei periodi più miti, virava su una birra chiara. Leggeva, osservava, a volte si lasciava andare in timidi cenni di complicità nei confronti dei conoscenti: «Stare al bar è come stare a teatro –diceva – con la differenza che a teatro non puoi giocare a scacchi».
Carne Salà
Bagarre elettorale, clamore che sale. L’aria si fa tesa, ecco qui la grande resa. Campagna elettorale, sapore di maiale. Aperta la contesa, vincerà la Grande Chiesa. Quella che parte da Che Guevara, e arriva fino a Madre Teresa.
Latte acido
Scandalo derivati, Profumo annuncia: «I titoli tossici mandati a San Patrignano».
Monte dei Paschi, una storia italiana dal 1472: ABI Caritas et Amor, Deus ibi est.
Disimpegno Canino
Sembra quasi che ci si diverta, a parlar del negativo. Sembra quasi che ci si diverta, a subirlo. E s’impreca e si bestemmia: “ce lo mandano addosso, ce lo tirano in testa!”. Eppure, a pensarci bene, il negativo lo partoriamo, è nutrito dal nostro grembo. E poi, vomitato nell’aria. Ma non è questo il problema. Il problema è che dovremmo mollarlo, invece ce lo andiamo sempre a riprendere, perché siamo abituati ad averne bisogno. Questione di guinzaglio: è il guinzaglio a rovinarci tutto.
Vito Alius
Vito Alius era individuo raro. Vestiva in modo ricercato, senza che questo gravasse particolarmente sulle sue tasche. Viveva solo. Era lui l’unico essere vivente in quella mansarda allestita ad appartamento. Qualcuno in passato aveva cercato di consigliargli un cane, «per avere un po’ di compagnia». Niente da fare: «il cane non sta bene in città –rispondeva Alius- , in città soffre l’uomo, figuriamoci il cane. Al cane non sarebbe mai venuto in mente di costruire un agglomerato così puzzolente. I cani stanno bene in campagna».
Eh sì che ne sapeva, di vita in campagna. In fondo ci era nato, in campagna. Nessuno sa bene dove, né quando, approssimando forse ad una cinquantina d’anni fa. Forse qualche anno in più. Il tutto avvenne da qualche parte, nel Centro Italia. Rieti sostengono alcuni, anche se non v’è certezza. Questo perché Alius aveva l’abitudine di parlare solo al presente, e mai al passato. Tantomeno sulle sue abitudini da fanciullo o sulle sue origini: come se fosse nato oggi, come se dovesse rinascere domani. Cosa curiosa, giacché Alius era appassionato di Storia, tanto da saper recitare a menadito date e battaglie di qualsiasi epoca, e non solo. Intrighi, linee politiche, retrospettive: la sua conoscenza pareva talvolta essere infinita. L’Alius si poteva ascoltare per ore, forse anche per giorni. Mai al passato però. Sempre al presente.
La mansarda era di colori accesi: la parte verso il lucernaio, quella ad est (questo se si considerava l’entrata principale come centro del mondo) era di colore giallo. Nella parte ad ovest, dove un fornelletto minimale ospitava la teiera che regnava incontrastata da mattina a sera, il colore dominante era il blu.
Sulla parete più grande, quella prospiciente all’ingresso, c’era una tela raffigurante una copia di un quadro di Dalì: “Ritratto del violoncellista Ricardo Pichot”. L’Alius sosteneva di non esserne responsabile, tuttavia non sembrava molto credibile. Quasi si vergognasse di appendere immagini in camera. Che poi, non che non fosse attratto dall’Arte: l’Alius si diceva grosso filologo. E in effetti l’eloquenza non mancava: a volte a latitare era la volontà di eloquire.
Se solo avesse voluto, avrebbe potuto partire in una digressione sull’epopea dello sfruttato dalla prima Rivoluzione Industriale in poi, appuntando con orgoglio il fatto di “non essere comunista”. E sia chiaro, dell’uomo di destra aveva ancor meno. All’Alius non piacevano le divisioni: a malapena sopportava la divisione cromatica della sua mansarda. Era incuriosito da ogni forma di mistero, verso cui aveva un approccio cauto ma affascinato, come fosse una belva feroce: «Se la parola è di Cristo, di chi è l’arte di maneggiarla?», era solito ripetere. Pareva avulso, pareva fluttuare. In realtà scavava sottoterra, per andare a trovare “dove cadono i fatti”: «Se ac-cade qualcosa, il moto è sempre dall’alto verso il basso –gracchiava- Non si è mai vista ac-cadere una cosa dal basso verso l’alto». E mal digeriva anche il potere, e le gerarchie costituite, e ti diceva che ne aveva tutte le ragioni. E che lui riconosceva i quattro elementi, gli unici a cui tutti dovrebbero sottostare, “e in realtà tutti quelli che incontri nella vita, anche i più stronzi, lo fanno. Per mancanza di alternative”.
Una mattina, sorseggiando il tè, venne interrotto da un rumore sul pavimento. Il cucchiaio era volato a terra, spostato da un colpo di vento che entrò dal lucernaio: «Ci soffio e tutto va via –pensò-. Come quando ti cade la forchetta a terra, e ci soffi sopra. L’aria è il più potente degli elementi, basta un soffio d’aria per far crollare l’ordine, e anche il disordine. L’aria pulisce. L’aria sostituisce. Basta un soffio d’aria per spazzar via batteri, e misteri. Perché i misteri son batteri, e i batteri son misteri».